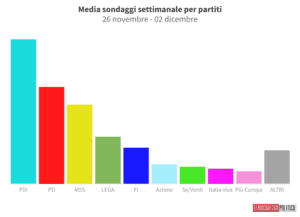Riforma del lavoro, quei due equivoci sul “modello tedesco”

Nella conferenza stampa del 1° settembre, il presidente del consiglio dei ministri (coadiuvato dal ministro Maria Elena Boschi e dal sottosegretario di stato alla presidenza del consiglio Graziano Delrio) in merito alla riforma del lavoro ha parlato della necessità da parte dell’Italia di fare le riforme, rimarcando come sul fronte lavorativo “la Germania è un sistema da prendere a modello per tutti noi”.
Alla dichiarazione del capo del governo sono seguiti consueti approfondimenti e report, da parte della stampa italiana, sul mercato del lavoro tedesco. Tra alternanza scuola lavoro, detassazioni varie e consigli di sorveglianza (ben distinti però da quelli di gestione) presidiati dalle organizzazioni sindacali. Al tempo stesso il dibattito ha inscenato la solita querelle “austerità sì-austerità no” che ha assunto (come spesso capita nel povero dibattito pubblico nostrano) la fisionomia di un “Merkel sì-Merkel no”.
Sul tema però emergono due vizi di fondo e due grandi equivoci che devono partire da una premessa: se oggi la Germania è considerata un modello sul fronte dell’efficienza economica e del rigore dei conti pubblici è grazie all’azione politica della cosiddetta “Agenda 2010” dei governi rosso-verdi dal 1998 al 2005. Un’agenda composta da riforme strutturali, ma così strutturali da portare ad una faida e ad una divisione interna alla sinistra teutonica con l’abbandono dell’Spd da parte dell’ex ministro dell’economia Oskar Lafontaine (che formò assieme al Pds di Gregor Gysi, erede della Sed tedesco-orientale, la Die Linke). Un addio e una divisione non molto dissimile ad altri traumatici abbandoni della sinistra italiana da Livorno in poi. Lungi dal togliere alla Merkel i suoi meriti (senz’altro ha tenuto la barra dritta sulla contabilità pubblica), occorre però sfatare due aspetti legati al modello tedesco.
In primo luogo, e questo avviene soprattutto quando si parla di flessibilità vs austerità, è quanto mai scorretto definire la politica economica della Germania degli ultimi vent’anni come frutto del liberismo e dell’impostazione neo-classica (l’ultimo ad accusare il governo in questo senso è stato il vicedirettore del Financial Times Wolfgang Munchau). L’idea secondo cui la Merkel porta avanti la dottrina liberista si basa su un’analisi del tutto parziale e non esauriente: per flessibilità si intende la possibilità di investire e spendere di più per stimolare la crescita senza porsi nel breve periodo problemi di pareggio di bilancio. Un’impostazione molto “keynesiana” (in quanto si basa sul pubblico come esclusiva leva per far ripartire l’economia nazionale) e tipica di gran parte della sinistra europea. Sostenendo la Merkel l’esatto contrario (prima il rigore dei conti pubblici, poi casomai allentiamo i cordoni della borsa) è una nota esponente della scuola di Chicago. Un argomentazione dunque che non si basa su dati di fatto reali, ma dalla semplice negazione di un presupposto.
La Germania è patria del cosiddetto “capitalismo renano”, una visione dell’economia capitalistica diametralmente opposta a quella anglosassone secondo cui il profitto è un fine e non un semplice mezzo. Impostazioni diverse da non poter essere scambiate o fraintese, soprattutto in una realtà a “capitalismo maturo” (per dirla alla Marx) come la Germania. Al tempo stesso l’idea secondo cui la politica economica di Berlino sarebbe la massima rappresentazione del liberismo economico risulta essere un errore di ingenuità politica, che vede al centro della contrapposizione europea non tanto la divisione “reale” tra paesi del sud e paesi del nord (tradotto: paesi coi conti pubblici in dissesto e paesi coi conti pubblici in ordine) ma quella “ideale” tra principali famiglie politiche continentali (socialisti vs popolari). La Finlandia fa asse con la Germania che al tempo stesso fa asse con l’Olanda non per la comune adesione ad un partito politico europeo, ma per le caratteristiche storicamente e culturalmente intrinseche a quei paesi.
In secondo luogo non bisogna dimenticare che ogni qual volta si parla di voler fare “come la Germania” sul fronte del mercato del lavoro bisogna rapportarsi con un sistema delle relazioni sindacali che da sempre fa storia a se a Berlino. In un mondo del lavoro in cui aumenta sempre di più la piaga del precariato (strutturalmente impossibile da tutelare sul fronte sindacale e centrale), si chiede al sindacato di ripensarsi e riformarsi per adempiere ai suoi storici obiettivi. Da qui l’impostazione renziana secondo cui il governo ascolta tutti, ma poi agisce in ogni caso. La fase della “concertazione” lascia dunque spazio a quella della “consultazione”. E l’elemento concertativo tra governo e organizzazioni dei lavoratori è il punto centrale di tutte le pratiche di cogestione delle aziende.
Certo, si potrà dire non a torto che il sindacato in Germania è profondamente diverso (anche dalle unions americane…e per fortuna Berlino è abitata da una di liberisti!). Ma proprio per questo appartiene alla categoria delle astrazioni politiche pretendere di portare in Italia un modello come quello tedesco senza i sindacati come quelli tedeschi.