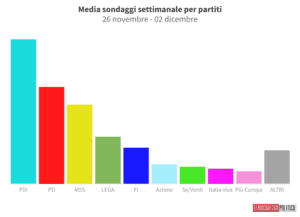Israele: Frammenti di memoria di mescolano al presente

06/10/2013
La guerra d’Ottobre
Accade talvolta che il terrore di una strage continui ad alimentare dopo molti anni il focolaio di un orgoglio nazionale riservato e quasi impercettibile.
Sono trascorsi esattamente quarant’anni dal 6 Ottobre 1973, dalla guerra che l’Egitto e la Siria si apprestavano a combattere contro Israele, appena sei anni dopo la Guerra dei Sei Giorni. Le sinagoghe erano gremite di fedeli intenti a celebrare una delle festività fondamentali del calendario sacro ebraico; ma a spazzare via la solennità dello Yom Kippur è stato un contrattempo insidioso, annunciato dalle sirene d’allarme che scuotevano le strade di tutto il Paese.
Oggi, a distanza di quarant’anni, si può essere tentati dal cedere il passo ad un’indulgenza semplicistica, che vorrebbe ridurre la Guerra del Kippur ad un blitz fallito, in fondo spezzato dalla controffensiva israeliana che respingeva prontamente l’avanzata verso i territori già sottratti agli arabi nel 1967.
Ma un risentimento nazionale più forte della vittoria nasceva dal bilancio di oltre ventimila militari caduti (tra israeliani e arabi), cui si aggiungevano i dispersi e i prigionieri.
Al di là del cessate il fuoco imposto alla fine di Ottobre dagli Stati Uniti e dall’URSS, restava l’orrore vissuto dai civili: una realtà che non avrebbe potuto precipitare nel pozzo dell’indifferenza.
Solo un anno più tardi, nel 1974, l’altopiano del Sinai e le Alture del Golan venivano smilitarizzate, attraverso una soluzione apparentemente pacifica, che mascherava un malcontento politico interno. La credibilità politica di Golda Meir, la Lady di ferro del Partito Laburista perdeva lustro, fino a che Rabin divenne Primo Ministro. Fu poi la volta del leader conservatore Begin, il primo tuttavia a siglare un accordo di pace con al-Sadat. Il 1979 segnava la restituzione del Sinai all’Egitto, rafforzava il controllo israeliano in Cisgiordania, ma la drammaticità della guerra aveva da tempo annegato qualsiasi aspettativa.
Tutte le pedine sul tavoliere
La vittoria del 1973 è stata l’effetto di una situazione di emergenza, quasi una diga frettolosamente costruita per arginare la paura di un nuovo massacro della comunità ebraica.
Da quel momento il timore e l’orgoglio imponevano che l’inadeguatezza fosse vinta dalla corsa agli armamenti – tecnologici e sofisticati – che in poco tempo hanno reso Israele la potenza militare più invidiata di tutto il Medio Oriente.
Il Paese si assestava su posizioni conservatrici e l’intensità dei conflitti arabo-israeliani ha contribuito a ridisegnarne la psicologia. Non desta meraviglia che il 29 Novembre scorso, quando l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite riconosceva la Palestina come Stato osservatore non membro, le colonie ebraiche in Cisgiordania esprimessero lo stesso sdegno condiviso dal Governo israeliano e precisavano che la risoluzione non riconosceva comunque l’Autorità Palestinese come Stato.
Salutata dagli stessi israeliani come la sconfitta di Netanyahu, il primo respiro internazionale della Palestina ha finito con il rendere sempre più tortuoso il sentiero dei negoziati di pace.
L’incisiva battaglia diplomatica degli Stati Uniti vorrebbe persuadere Tel Aviv che le prospettive di pace richiedono il coraggio di scommettere su una nuova formula.
La Casa Bianca esorta il Governo israeliano a raggiungere un accordo sul futuro Stato di Palestina. Da parte sua, Israele analizza la tormentata damiera mediorientale da un’altra angolazione, mostrandosi certo che ben altre sono le priorità. Per ricucire i brandelli dell’intera area occorrerebbe puntare primariamente su un’evoluzione della crisi egiziana e del conflitto siriano: non si può continuare a far finta che Israele e Palestina siano le pedine che debbano sempre essere mosse per prime.
Che poi, affrontando il discorso in termini più generali, l’arte della mediazione sia la sfida perpetua dello Stato ebraico, questo è un fatto di cui l’intera comunità internazionale è consapevole. Proprio nel corso dell’incontro che si è svolto a Parigi nell’ultima settimana, i membri del Comitato Esecutivo dell’Unesco hanno condannato attraverso sei risoluzioni l’atteggiamento di Tel Aviv, che per mesi ha negato alla delegazione il consenso per una visita che verificasse la conservazione di numerosi siti della Città Vecchia di Gerusalemme. Non a caso, l’Unesco è stata la prima agenzia internazionale a riconoscere lo Stato di Palestina come membro a pieno titolo, già a partire dal 2011.
Conciliazione e risentimento
Una politica non propriamente diplomatica sembra ultimamente appannare l’apprezzamento internazionale nei riguardi di Tel Aviv: le divergenze investono i rapporti di vicinato con la comunità palestinese, ma si proiettano anche sulle esternazioni dell’Iran di Rohani. Tuttavia, che le relazioni tra gli Stati Uniti e lo Stato ebraico abbiano subito un’inclinazione non pare una valida argomentazione per dubitare della solidità dell’asse, potendosi parlare tutt’al più di un lieve imbarazzo. Nel corso della sessione annuale dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il Premier Netanyahu ha invitato gli Stati Uniti a non cedere all’inganno di Rohani, dichiarando che Israele è pronto a combattere anche da solo, pur di contrastare il programma nucleare iraniano. È stata una reazione carica di deterrenza, il cui tono deciso sembra tradire preoccupazioni sedimentate da decenni nella coscienza dello Stato israeliano.
Un approccio più cauto è perseguito invece dagli Stati Uniti, che – pur lasciando sul tavolo delle trattative tutte le opzioni possibili – vorrebbero preservare le sfumature di una positiva fase di negoziazione, a patto che l’Iran acconsenta al disarmo. È chiaro che il Presidente Obama accoglie favorevolmente le prospettive di dialogo che spirano dall’Iran, pur senza spalancare le porte a Teheran.
Le rassicurazioni di Washington hanno l’aria di una messa alla prova per lo stesso Israele, uno Stato fortemente militarizzato che riveste un ruolo chiave in tutto il Medio Oriente.
Sono state proprio le contingenze storiche a mostrare che un’emergenza semipermanente può talvolta cedere alla seduzione del militarismo. Ma adesso che gli occhi del mondo sono puntati su una Siria che brucia da oltre due anni, la semplice provocazione che un altro punto della polveriera possa esplodere suona come un’intimidazione di pessimo gusto.
È piuttosto il momento di fare dei passi indietro, se non altro per onorare la memoria di un passato già drammatico.
Luttine Ilenia Buioni