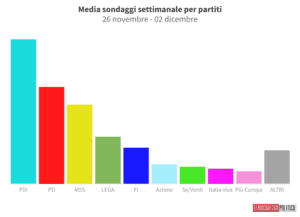La felicità davvero

Di lo Scorfano:
Quando entro in classe, in seconda, c’è una ragazza che piange, da sola in un angolo. Non so bene cosa dire ovviamente: allora faccio un segno alla sua compagna di banco e le dico (ma solo a gesti, quasi senza parlare): «Prendila e accompagnala fuori». Lei si alza, le due ragazze escono, la porta si chiude alle loro spalle e davanti ai nostri occhi un po’ stupiti, i miei e quelli degli altri ragazzi (cinquanta occhi esclusi i miei, per la precisione). Allora chiedo se qualcuno sa cosa sia successo (e penso magari a un brutto voto nell’ora precedente) e una voce non identificata mi dice: «Ha litigato con il suo ragazzo, stamattina». Io smetto di scrivere sul registro e dico, un po’ a voce alta, un po’ parlando con me stesso: «Ah, l’amore… Vi farà soffrire alla vostra età, l’amore…» E poi sarei pronto per cominciare la lezione.
Ma una mano si alza e uno sguardo si rabbuia un po’, lo vedo bene. E la voce (maschile) mi dice: «Ma dopo non si soffre più, per amore?» «Mah, dico io, si soffre sempre in realtà. Magari si soffre per altre cose, magari a un certo punto si trova anche, l’amore… Io l’ho trovato, per esempio». Ed è forse quest’ultima osservazione che li mette in allarme; un’osservazione molto personale, in effetti. E un’altra voce (femminile) mi dice: «E quindi adesso è felice?» Io sorrido. Poi dico: «Sì, per quanto riguarda l’amore sono felice… Poi ci sono anche altre cose, è ovvio. La salute, il lavoro, gli amici, i genitori che invecchiano, i soldi, la squadra del cuore che perde… (qualcuno ride) I pensieri non mancano mai, le lacrime servono sempre». «Ma c’è un periodo della vita in cui lei è stato davvero felice?» Ed è sempre la stessa voce che chiede, quella femminile; e allora io mi fermo, poso la penna sulla cattedra e li guardo. E provo a dire (badate bene: ci provo, che non è mica che uno ha queste risposte pronte, nella sua vita un po’ felice un po’ turbata); provo a dire:
«Be’, dipende. Ci sono momenti, periodi, mesi e giorni di felicità. Però ci sono anche problemi e fastidi e rotture e compiti da svolgere e doveri e tutto quello che già c’è nelle vostre vite, di adesso. Non è che a vent’anni sarete felici, o a trenta o a quaranta. Si è felici sempre come si hanno problemi sempre; si è felici se si riesce a dare peso e importanza a quello che si ha, per esempio, a non desiderare troppo di altro, senza per questo smettere di desiderare qualcosa, che anche questo, in certo modo, è felicità. Ma “felicità” è una parola astratta, un contenitore vuoto, siamo noi (siete voi) che dobbiamo riempirlo di cose concrete: che sono le nostre giornate, i nostri affetti, le cose che facciamo che ci vengono bene, quello che sappiamo migliorare, i progetti a cui abbiamo la voglia e la forza di dedicarci. E quindi no, insomma: non c’è un periodo della vita in cui si è più felici che in un altro. Voi siete giovani e dovreste essere felici già solo di questo, di tutto il futuro che avete davanti. Ma lo so che non basta; lo so che volete dell’altro. E anch’io voglio dell’altro. Tutti vogliamo dell’altro. E già questo basta a renderci non perfettamente felici. Però, ragazzi, si può essere in parte felici e soprattutto dare rilievo a quella parte per cui si sta bene, sapendo che è qualcosa, più di qualcosa, sapendo che forse è già molto…»
E insomma, io sono lì, in discreta confusione (l’avete capito), che cerco una risposta che abbia un senso e che non sia né una visione fiabesca né un quadro inutilmente tragico, sono lì che annaspo dentro le mie parole mentre le due ragazze che erano uscite rientrano e la prima non piange più e l’altra le fa un pizzicotto sulle braccia e lei sorride pure. E allora mi viene in mente una cosa, a cui forse non avevo mai più pensato; ma che forse mi era sempre rimasta lì, nella testa, nascosta in chissà che angolo.
Mi viene in mente che da ragazzino giocavo al pallone nel prato vicino a casa mia, con i miei amici del quartiere. Erano gli anni della scuola media, avrò avuto dieci o undici anni. Ma io non ero capace a giocare a pallone, sempre stato negato. Facevo quello che potevo, ma era troppo poco e i miei amici spesso se la prendevano con me per un passaggio sbagliato o un mancato controllo ed ero sempre tra gli ultimi a essere scelto dai «capitani» e questo mi faceva soffrire. E poi, mi ricordo, ci fu un giorno che eravamo in pochi e mancavano proprio quei tre o quattro ancora più scarsi di me, quelli che normalmente erano relegati in porta, tanto erano scarsi. E toccò quindi a me, quel giorno, andare in porta. E io vivevo male quella cattiva sorte: un po’ perché era il segno del mio pochissimo talento, un po’ perché mio padre era stato, da giovane, un portiere. Piuttosto bravo, tra l’altro. E mi raccontava spesso delle sue imprese sportive, e io sapevo che ero un po’ una delusione calcistica, come figlio: perché giocavo molto male, e in porta peggio che in difesa.
M;a quel giorno fu diverso, non so perché. Mi ricordo che quasi subito ci fu in tiro forte, di uno di quelli bravi (si chiamava Massimo), una palla violenta di cui io avevo avuto paura, appena l’avevo vista partire. Ma mi ero messo in traiettoria e, non so come, l’avevo presa, anche se mi aveva fatto male alle braccia. E i compagni di squadra mi avevano dato pacche sulle spalle, mi avevano detto «Bravo». E poi ci furono altri tiri e colpi di testa e attaccanti soli davanti a me e io che mi buttavo per terra, tra le loro gambe, saltavo verso la traversa, e paravo tutto, non so come, non so per quale miracolo, forse perché mi sentivo bene, perché ero bravo, perché gli altri mi guardavano pensando che fossi bravo.
E poi la partita finì, qualcuno portò via il pallone, io avevo parato quasi tutto e avevamo vinto nettamente e allora mi misi a correre, verso casa. Perché dovevo dirlo a mio padre. Dovevo raccontargli subito di quelle parate, di come mi buttavo e deviavo la palla oltre la traversa o al di là del palo. E correvo per le scale, i soliti tre piani, e facevo i gradini due alla volta e volevo dire tutto subito a mio padre, che era appena rientrato dal lavoro. Ed ero contento che tra pochi secondi sarebbe successo.
Ecco, insomma, quel momento lì. Quello sulle scale. Quei gradini senza fiato.
Insomma sì: in quel momento, ora me lo ricordo, io credo di essere stato davvero felice, perfettamente. La felicità perfetta, limpida e senza ombre. Mentre correvo per dire una cosa a mio padre. Ed ero, mi pare di poterlo dire, felice davvero.
Ma poi, ai miei ragazzi, non l’ho detta questa cosa. Sono stato zitto, e anche loro non hanno più parlato: abbiamo fatto la nostra lezione di storia, sui cesaricidi. Ho avuto paura che ci rimanessero male, vi dico la verità. Magari mi avrebbero chiesto com’era andata la partita successiva e io avrei dovuto dire loro che la partita successiva ero andato di mia spontanea volontà a fare il portiere e avevo preso una decina di gol. E così quella dopo ancora. Perché non ero mica un bravo portiere, era stato solo un caso. E mi pareva brutto dire loro che la felicità davvero esiste solo per un attimo, mentre perdi il fiato sulle scale e poi non la ritrovi più. Non mi pareva il caso, e quindi sono stato zitto.