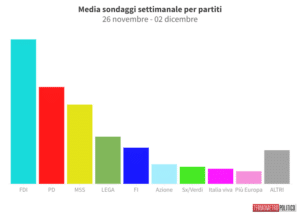C’è una guerra commerciale camuffata che si combatte sul mare (e i suoi traffici)

C’è una guerra commerciale camuffata che si combatte sul mare (e i suoi traffici)
C’è una battaglia che si sta combattendo lontano dai riflettori, nelle sale asettiche dell’International Maritime Organization, ma le sue conseguenze potrebbero ridisegnare gli equilibri del commercio mondiale nei prossimi decenni. Da una parte l’Europa, determinata a spingere verso un futuro a emissioni zero. Dall’altra gli Stati Uniti di Trump, che parlano apertamente di “neocolonialismo climatico” e minacciano sanzioni contro chiunque osi sfidare la loro visione.
Al centro dello scontro: le navi cargo che solcano gli oceani trasportando il 90% delle merci mondiali. Giganti d’acciaio che emettono più di 1 miliardo di tonnellate di CO2 equivalente ogni anno – l’1,4% delle emissioni globali – e che finora sono rimasti sostanzialmente fuori dal radar delle normative climatiche internazionali.
Questo mese potrebbe cambiare tutto. O nulla.
La proposta che ha fatto esplodere le tensioni
Ad aprile 2024, l’IMO ha fatto quello che molti consideravano impossibile: approvare una bozza di regolamento che stabilisce l’azzeramento delle emissioni nette di gas serra del settore marittimo entro il 2050. Non raccomandazioni vaghe o obiettivi simbolici, ma il primo strumento normativo al mondo che impone limiti vincolanti alle emissioni di un intero settore industriale.
Il regolamento punta dritto al cuore del problema: le grandi navi oceaniche oltre le 5.000 tonnellate di stazza lorda, responsabili dell’85% delle emissioni totali del trasporto marittimo globale. Per queste navi, dal 2027 – se l’accordo verrà ratificato questo mese durante la sessione straordinaria del Marine Environment Protection Committee – scatterebbero due meccanismi paralleli.
Il primo è uno standard globale sui carburanti che impone una riduzione progressiva dell’intensità di emissioni: meno gas serra per ogni unità di energia utilizzata, anno dopo anno, fino ad arrivare allo zero netto nel 2050. Il secondo è una misura economica che trasforma il problema in un sistema di incentivi e penalità: chi sfora le soglie dovrà acquistare crediti per compensare, chi rimane sotto potrà vendere i propri crediti e beneficiare di premi finanziari.
Sulla carta, un capolavoro di ingegneria normativa che bilancia ambizione climatica e realismo economico. Nella realtà, una bomba geopolitica innescata.
“Neocolonialismo climatico”: l’accusa americana
Quando il Segretario di Stato Marco Rubio, insieme ai Segretari all’Energia Chris Wright e ai Trasporti Sean Duffy, hanno rilasciato la loro dichiarazione congiunta, non hanno usato mezzi termini. Le parole scelte non lasciano spazio a interpretazioni diplomatiche:
“Gli Stati Uniti si muoveranno per imporre questi rimedi contro le nazioni che sponsorizzano questa esportazione neocoloniale di normative climatiche globali guidata dall’Europa.”
Traduzione: se ratificherete questo accordo, preparatevi a subire sanzioni commerciali da Washington.
La narrazione di Trump è semplice quanto efficace: quello che l’Europa presenta come regolamento ambientale è in realtà una tassa globale sul carbonio mascherata, destinata ad aumentare i costi del trasporto marittimo fino al 10%. E chi pagherà il conto? Le aziende americane, i consumatori americani, l’economia americana.
È una guerra commerciale travestita da dibattito climatico, sostiene l’amministrazione Trump. Le normative europee imposte al resto del mondo attraverso organismi internazionali che gli Stati Uniti considerano sempre meno legittimi. Un tentativo di esportare valori e priorità che l’America non condivide e non intende accettare.
L’Europa non arretra: “Una pietra miliare”
Bruxelles ha risposto con una dichiarazione altrettanto netta. Il quadro normativo per l’azzeramento delle emissioni va adottato perché rappresenta “una pietra miliare significativa nella lotta contro i cambiamenti climatici”. Non ci sono margini di trattativa su questo punto: il pianeta non può permettersi di aspettare che Washington cambi idea.
La posizione europea si basa su una semplice constatazione: il trasporto marittimo è uno degli ultimi grandi settori industriali a rimanere sostanzialmente deregolamentato dal punto di vista delle emissioni. Mentre l’aviazione ha iniziato a muoversi (seppur lentamente), mentre l’industria manifatturiera è sottoposta a normative sempre più stringenti, le navi cargo hanno continuato a bruciare combustibili pesanti e sporchi praticamente senza vincoli.
L’accordo IMO chiuderebbe questo buco normativo. E l’UE è determinata a vedere questo risultato concretizzarsi, anche se significa scontrarsi frontalmente con gli Stati Uniti.
Cosa succede adesso: il voto che conta
Questo mese si terrà la sessione straordinaria del Marine Environment Protection Committee che dovrà votare l’adozione formale degli emendamenti. È un momento cruciale che determinerà non solo il futuro delle emissioni marittime, ma anche l’assetto delle relazioni commerciali transatlantiche.
Se l’accordo viene approvato, il calendario è già scritto:
- 2027: entrano in vigore i nuovi requisiti sugli standard dei carburanti
- 2029: parte il meccanismo dei crediti di emissione
- 2050: obiettivo emissioni nette zero per il settore
Ma la domanda vera non è se l’accordo passerà – con l’Europa compatta e il sostegno di molti Paesi in via di sviluppo che vedono nel meccanismo dei crediti un’opportunità economica, l’approvazione sembra probabile. La domanda è: cosa farà Trump?
Le sanzioni minacciate sono vaghe nei dettagli ma chiare nell’intento. Potrebbero colpire i Paesi che ratificano attraverso dazi aggiuntivi sulle merci trasportate via mare, restrizioni all’accesso ai porti americani per navi registrate in quei Paesi, o ritorsioni commerciali più ampie.
È uno scenario che ricorda le guerre commerciali del primo mandato Trump, ma con una posta in gioco ancora più alta: non si tratta di proteggere l’industria dell’acciaio o dell’alluminio, ma di decidere se gli Stati Uniti accettano di partecipare a un sistema multilaterale di governance ambientale o se scelgono l’isolamento unilaterale.
Il paradosso del 10%
L’argomento del “10% di aumento dei costi” usato dall’amministrazione americana merita un’analisi più attenta. È vero che introdurre carburanti più puliti e pagare crediti di emissione avrà un costo per gli operatori marittimi. Ma quanto di questo costo si tradurrà effettivamente in aumenti per i consumatori?
Gli esperti del settore sono divisi. Alcuni economisti sottolineano che i costi del carburante rappresentano solo una parte del prezzo finale di trasporto, e che l’industria ha storicamente dimostrato capacità di assorbire incrementi di costo attraverso efficientamenti operativi e innovazione tecnologica.
Altri fanno notare che l’aumento dei costi non sarà uniforme: le compagnie che investono in tecnologie pulite e navi moderne potrebbero addirittura beneficiare del nuovo sistema, vendendo crediti di emissione e costruendosi un vantaggio competitivo. Sarebbero penalizzate solo le compagnie meno efficienti e più inquinanti – esattamente l’obiettivo del regolamento.
Trump, dal canto suo, scommette sul fatto che la minaccia di costi più alti risuoni politicamente meglio di complessi ragionamenti su esternalità ambientali e benefici di lungo termine. E potrebbe avere ragione: in un momento di inflazione e tensioni economiche, l’idea di “tasse globali” imposte da organismi internazionali è un nemico perfetto da brandire.
Oltre lo scontro: cosa significa per il clima
Mentre Washington e Bruxelles si lanciano accuse reciproche, c’è un dato che rimane sullo sfondo ma che definisce l’urgenza reale della questione: più di 1 miliardo di tonnellate di CO2 equivalente emesse ogni anno da un settore che continua a crescere.
Le proiezioni indicano che, senza interventi normativi, le emissioni del trasporto marittimo potrebbero aumentare fino al 50% entro il 2050, vanificando completamente gli sforzi di riduzione in altri settori. Non si tratta di ambientalismo ideologico: è matematica climatica.
Il regolamento IMO rappresenta il primo tentativo serio di mettere il settore marittimo su un percorso compatibile con gli obiettivi dell’Accordo di Parigi. Può essere imperfetto, può essere migliorato, ma è un punto di partenza che la comunità scientifica considera necessario.
Rifiutarlo significa accettare che una fetta significativa dell’economia globale resti fuori da qualsiasi sforzo di decarbonizzazione. E questo, secondo molti analisti, è un lusso che il pianeta non può più permettersi.
SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK TWITTER INSTAGRAM
Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it