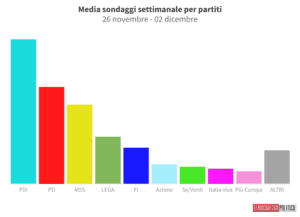Marbury: quando avere tutto non è ancora abbastanza

Ci sono storie in cui i protagonisti lottano per ottenere ciò che più desiderano al mondo, realizzano i loro sogni e vivono felici e contenti. Altre in cui la lotta termina con una sconfitta, e se va bene con una morale da imparare e qualche esperienza da raccontare ai nipotini, se va male con un mucchio di fastidiosi insetti ronzanti stretti nella mano chiusa. Poi ci sono quelli che invece ottengono tutto, ma proprio tutto, schifosamente tutto in maniera perfetta, ma non riescono a goderselo, a farlo fruttare o a esserne semplicemente felici. E scrivono una storia diversa. Quella che state per leggere ora è una di queste. La storia di Stephon Xavier Marbury. Quando nasci nel ghetto di Coney Island, Brooklyn, in uno dei tanti “projects” (agglomerati composti delle più svariate tipologie di umanità, più che case popolari o grattacieli di bassa qualità) di New York, ci sono ottime probabilità che in cima alla lista dei tuoi desideri ci sia diventare un campione dello sport. Magari della pallacanestro, che tanto successo e seguito raccoglie in città. Magari come playmaker, ruolo per il quale gli autoctoni hanno una venerazione particolare. In famiglia ci hanno già provato in diversi, quasi tutti con risultati più o meno deludenti. Sì perché i fratelli Marbury, purtroppo per loro, sono nati quasi tutti senza il talento sufficiente per fare il grande botto. Tutti a parte il sesto (su sette), Stephon, che vede la luce per la prima volta il 20 febbraio del 1977. Lui il basket ce l’ha nel sangue, e si vede. La nomina a “mr. Basketball” per lo stato di New York quando frequenta la locale Lincoln High School è già un segno. La metropoli per eccellenza si accorge di lui. La stampa locale, sempre molto equilibrata e mai propensa alle esagerazioni (un po’ come la nostra col calcio, per intenderci), lo definisce il nuovo grande playmaker newyorkese dopo due mostri sacri come Marc Jackson e Kenny Anderson. La stagione giocata al college con Georgia Tech è solo un trampolino per la NBA, che lo sceglie (al numero 4 assoluto del draft in cui alla 1 finisce Allen Iverson) coi Bucks di Milwaukee, salvo scambiarlo subito a Minnesota per Ray Allen e una prima scelta futura.
Pausa per riprendere un attimo fiato. Si parte da uno scricciolo che impara sul cemento dei playground a incassare colpi proibiti dai fratelli prima ancora che a tirare a canestro, e si arriva alla quarta chiamata assoluta nella lega più forte del mondo. Si salta dalla povertà del ghetto ai contratti milionari della NBA. Quanto a sogni realizzati.. Bene no? Ok, Minneapolis non sarà il centro del mondo, e nemmeno tra le dieci località più cool che vi vengono in mente, ma se si parla di pallacanestro nel 1996 ci sono pochi posti più adatti di quello per iniziare una carriera importante. Non fosse altro che per la presenza di un giovanotto che lascia già intravedere le stigmate di una potenziale super star nonostante i suoi 20 anni scarsi, tale Kevin Garnett. Sì, QUEL Kevin Garnett. Come coppia di giovani si è visto decisamente di peggio su cui costruire, e infatti nel Minnesota fanno il botto. Con i 15,8 punti a partita conditi con 7,8 assist per sera, Steph contribuisce in maniera decisa al raggiungimento dei play off, traguardo che da quelle parti non erano molto avvezzi a conquistare dopo che i Lakers avevano fatto su armi e bagagli nel lontano 1960 (in effetti avete mai visto molti laghi dalle parti di Los Angeles? Io non proprio. I Lakers devono infatti il loro nome alla zona dei laghi in cui originariamente la franchigia era nata, proprio a Minneapolis). Grande impatto, grande annata e grande conferma al secondo anno con il secondo accesso ai play off consecutivo. Ma poi che succede Steph? Ok, due anni su due fuori al primo turno, ma è una prassi attraverso cui sono passati in tanti. Perché allora quei continui mal di pancia? La stagione 98-99 si apre, anzi NON si apre, con il lockout, ovvero il blocco di tutte le attività da parte di proprietari e giocatori per ridiscutere i termini del contratto collettivo. Semplificando: tutti ci vogliono guadagnare di più. Nel marasma della situazione, che produrrà una stagione accorciata da sole 50 partite, Marbury chiede e ottiene di essere ceduto. Si tratta di voglia di tornare a giocare vicino a casa? No di certo, è solo la caccia ad una città con un mercato televisivo migliore, che lo metta in luce più facilmente. Macché, non gli piace semplicemente la città. No in realtà è solo geloso del contratto da oltre cento milioni di dollari che ha appena firmato Garnett. Forse è proprio Garnett che non gli piace. Queste, riassumendo, sono le voci che avreste potuto sentire in un bar qualsiasi della zona, o in cui sareste potuti incappare leggendo qualsiasi quotidiano sportivo. La sostanza non cambia, Marbury torna a casa. Più o meno. Con una trade che sta a metà tra la resa e la beffa, Steph viene mandato a giocare ai Nets, che oggi sono di casa proprio a Brooklyn, ma allora tenevano residenza nello stato del New Jersey. Vicino a casa in linea d’aria, ma sportivamente in un altro mondo. I Nets erano da sempre una delle barzellette della lega insieme ai Los Angeles Clippers, e il talento di Coney Island ci mise poco a capire che l’aria da quelle parti era decisamente più pesante che vicino ai grandi laghi. Di superstar a giocare accanto a lui nemmeno l’ombra. I play off per due anni guardati solo dal divano di casa, nonostante numeri sempre più importanti che gli valsero la convocazione all’all star game del 2001. Fu il suo momento più importante, con l’Est a ribaltare i favori del pronostico contro un fortissimo Ovest grazie ad Allen Iverson e proprio a Steph, che con due triple consecutive nel finale di partita diede ai suoi la vittoria. Attorno a quel momento felice, sportivamente parlando, solo sconforto, disperazione e sconfitte. Marbury si sentiva solo, privo di compagni all’altezza del suo talento e delle sue ambizioni. Mentre con una banda di comprimari e giocatori di secondo piano Iverson portava i suoi Sixers alle finali NBA, lui se ne restava a marcire sul fondo della eastern conference. Se i mal di pancia gli erano venuti a Minneapolis dopo due stagioni ai play off, figurarsi ora nel New Jersey. Una sera addirittura entrò in campo con le scarpe che recavano la scritta ALL ALONE NUMBER 33. E vi lascio indovinare chi avesse scelto quel numero di maglia dopo aver indossato da sempre il numero 3.
Ancora una volta arriva la cessione, ed insieme le scomode etichette di giocatore egoista e che non migliora i compagni, due dei peggiori insulti che un giocatore di basket, per giunta playmaker, possa ricevere. Il terzo insulto, che è anche il peggiore in assoluto, è quello di perdente, e stampa e addetti ai lavori non tardano ad appiccicarglielo addosso, specialmente dopo che Jason Kidd, l’uomo che è arrivato da Phoenix per lui nel New Jersey, porta i Nets a due finali consecutive (anche se, va detto, con un roster decisamente rinforzato rispetto al periodo in cui c’era Steph). A Phoenix le cose vanno meglio, il secondo anno arrivano i play off su cifre straordinarie che parlano di oltre venti punti e otto assist di media. Per intenderci, solo un uomo nella storia, Oscar “Big O” Robinson, era stato in grado di fare meglio di lui. Tanto, tantissimo talento insomma, ma Marbury continua a trascinarsi dietro la maledizione dell’addio ai Timberwolves. Una squadra forte così attorno non l’ha probabilmente più trovata. Resta ancora una speranza, quel sogno cullato fin da bambino, giocare al Madison Square Garden per la squadra della sua città. Alla fine, dopo tre anni a Phoenix, ottiene anche quello. La cessione ai Knicks lo rimanda a casa. È un tripudio. Lui è felice di essere tornato, la stampa è felice di avere materiale su cui scrivere, i tifosi sono felici di riabbracciare il figliol prodigo. La chiuderemmo anche qui, la storia, e se vi piacciono i lieto fine rose e fiori potrebbe essere anche una buona idea. Ma siamo nel 2004, e come intuirete in dieci anni qualcosina ancora è successa. L’antipasto è quello delle olimpiadi di Atene. Chi ama il basket se la ricorda bene quell’edizione, probabilmente l’ultima memorabile apparizione della nostra nazionale sul palcoscenico più importante del mondo. Un argento meraviglioso, una nazionale del destino con la perla della semifinale contro la Lituania che ancora oggi viene celebrata nei riti pagani delle palestre di tutto lo stivale. Marbury e Iverson guidano il non-più-dream team (appellativo tolto dopo l’orrendo sesto posto ottenuto ai mondiali di Indianapolis, in casa, due anni prima) alla riconquista dell’oro, puntando su una formazione di talento, gioventù ed esperienza di primissimo piano. Mancano alcuni campioni come Kobe e Kidd, ma ci sono i giovani Wade e James e veterani come Duncan e un allenatore stimatissimo come Larry Brown (prendete un appunto) a far ben sperare. Però si parte male male, con il ko in amichevole proprio contro di noi, e si finisce pure peggio, quando toccherà all’Argentina l’onore di abbattere Golia in semifinale, anche se quella versione dell’albiceleste non è che fosse proprio il Davide di turno. Stiamo andando fuori tema, ma la sostanza è che da Atene Steph e compagni tornano con una macchia indelebile che la medaglia di bronzo non può mitigare, ma casomai rende più grave. Tornato a New York, Steph trova una squadra ad attenderlo reduce da due pessime annate tra eliminazioni al primo turno e play off falliti. Si cerca di tornare subito ai fasti degli anni novanta, ma la Grande Mela sa essere una piazza terribile per la pressione che tifosi e media mettono sulla squadra. Il riassunto che si può fare di quegli anni è: DISASTRO. Arriva una qualificazione ai play off con record perdente di vittorie e conseguente eliminazione al primo turno ad opera degli ex cugini sfigati del New Jersey, una imbarazzante girandola di coach anche di altissimo livello (Lenny Wilkens e Larry Brown su tutti) e di scelte e scambi fallimentari, e Isiah Thomas che diventa general manager.
Marbury finisce presto nell’occhio del ciclone. La stella della squadra entra in conflitto con Brown e i suoi metodi, costringendo la dirigenza a licenziarlo, salvo poi fare altrettanto col suo successore (Thomas stesso passato dalla scrivania alla panchina) dopo essere stato estromesso dal quintetto e aver di conseguenza abbandonato la squadra. Atteggiamenti negativi a catena che affiancati a pessimi risultati di squadra gli tolgono completamente l’appoggio della stampa e dei tifosi. In più ci si mette anche la sorte a colpire basso. Dopo una partita in casa, nel 2007, il papà Don muore in seguito ad un attacco di cuore. Una mazzata ulteriore che porta il giocatore vicino alla depressione. Nell’estate 2008 cade anche la testa di Thomas ma l’arrivo di Mike D’Antoni non migliora la situazione, anzi se possibile la peggiora. Il coach gli preferisce Cris Duhon in regia, che con tutto il rispetto, a talento sta a Marbury come Gattuso a Messi. Quando Steph si rifiuta di giocare durante una partita, fa scendere la più classica delle ultime gocce. I Knicks lo tagliano, e lui finisce la stagione ai Celtics dove, dopo dieci anni, ritrova nientemeno che Garnett. Sembrerebbe il lieto fine di una favola, ma va male però anche lì, con l’eliminazione dei biancoverdi dai play off e la carriera di Starbury che si avvia ad un mesto viale del tramonto. Se gradite i finali cupi e tristi, io non so se vi voglio conoscere, ma questo sarebbe il momento giusto per smettere di leggere, però siamo nel 2009 e c’è l’ultimo lustro da raccontare. Marbury ha 32 anni, fisicamente è ancora a posto e potrebbe di certo giocare al massimo livello, ma intorno a sé ha fatto ormai terra bruciata. In NBA non si fida più nessuno del suo caratteraccio da prima donna stizzosa. È egoista, non migliora i compagni ed è un perdente. Il mantra su di lui è questo. Gli rimane la via dell’esilio, che per quanto ben pagato lo porta però lontano dai confini natii. E in effetti, se vieni dal ghetto di New York, poche realtà possono essere culturalmente più distanti di quella che si incontra per le vie della Repubblica Popolare Cinese. Lì però hanno una lega in forte crescita, hanno disponibilità economica e vogliono acquistare visibilità e per farlo non c’è niente di meglio di ex giocatori della NBA ancora in forma. Le prime 15 partite mostrano che il ragazzo ha ancora la classe di un tempo. Ci si aspetta che sia un periodo passeggero quello lontano dagli States, ma Starbury torna anche l’anno successivo e così quello dopo. Sempre grandi numeri, ma nessuna vittoria. Le critiche, anche quelle, sempre le stesse. Le conoscete già. Quel che è diverso invece è il mondo attorno a lui, un mondo dove fuori dal campo non si sgarra, un mondo in cui la cultura locale aiuta anche un’anima tormentata come la sua a ritrovare equilibrio e serenità. Non è un caso che nel 2012 arrivi così il suo primo titolo da professionista, vinto dopo aver cambiato squadra ed essere approdato nella capitale. Viaggiando a 45 punti DI MEDIA in semifinale e chiudendo la finale con 41 punti in gara 5 ed il conseguente e strameritato titolo di MVP, Steph spazza via per lo meno le critiche della parte orientale del globo. Merito, a sentir lui, del cambiamento che proprio la cultura locale gli ha fatto fare.
A Pechino, tanto per capire quanto impatto abbia avuto, gli hanno costruito una statua davanti al palazzo per celebrarlo a dovere. Il giocatore che abbandonava la squadra perché non partiva in quintetto oggi va agli allenamenti in metropolitana, studia la lingua e la cultura cinese e si sente finalmente in pace. A chi gli chiede della NBA e di un eventuale ritorno ha sempre risposto “non fa più al caso mio”. Un cambio di atteggiamento radicale, anche se da sempre Marbury ha avuto un lato che non esprimeva sul campo. Basti pensare alle numerose donazioni che non ha mai fatto mancare a tante persone bisognose, a partire dalle vittime delle torri gemelle, a quelle dell’uragano che colpì New Orleans ad altre e cospicue donazioni che superano complessivamente i cinque milioni di dollari. Non bastasse questo, Steph ha creato già ai tempi della NBA una sua linea di abbigliamento, la Starbury, che crea articoli sportivi a prezzi molto più contenuti dei colossi concorrenti (scarpe a meno di 20 dollari, per intenderci) perché anche i ragazzi più poveri potessero permettersi di avere un paio di scarpe nuove per giocare. Alla luce di tutto questo, pare evidente come Steph abbia ottenuto al di fuori del parquet i risultati più importanti. E poco importa se non era il lieto fine che si sarebbero aspettati in tanti all’inizio della sua carriera, o un finale amaro e tragico di quelli che fanno scalpore e tristezza allo stesso tempo. La storia al momento si ferma qui, e non è scontato che vi si debba leggere per forza la parola fine. Anzi, se volete sapere chi ha vinto il suo secondo titolo con la squadra di Pechino nel 2014, puntate sul forte sull’ex numero 33, che finalmente non si sente più “all alone”.