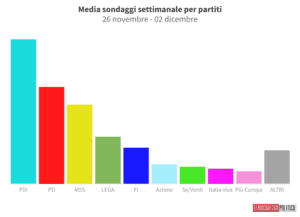Le murder ballad di Bruno Vespa

Contrariamente a quanto ci si potrebbe aspettare, la musica non risparmia molto all’ascoltatore: lamurder ballad pare invece proprio costruita secondo un canone ben preciso – pur con doverose variazioni sul tema – che consente la massimizzazione dell’esperienza percettiva nel fruitore.
Il racconto è spesso fatto in prima persona da parte dell’assassino, e raramente l’atto stesso dell’omicidio viene omesso dalla narrazione diretta; a seconda del messaggio che l’autore intende inviare, sono contenute le fasi di avvicinamento e adescamento della vittima, quanto piuttosto i momenti immediatamente successivi all’uccisione. A volte, in un richiamo alle favole dell’antichità classica, la morale dell’autore chiude la canzone.
La scelta della prima persona consente l’esplorazione dell’animo dell’assassino, ed in questo la scelta non appare difforme nel suo scopo ultimo da quella dei vari plastici di Porta a Porta. Le azioni e sentimenti dell’omicida vengono descritti in maniera esplicita, così come lo sono, nei momenti successivi alla morte della vittima, le reazioni di appagamento, colpa, rimpianto, paura. Una discesa infernale nella psicologia criminale che nulla ha da invidiare a quelle dei profiler delle serie televisive.
Ma la musica canta di temi universali, ed il genere delle murder ballad ha saputo crescere ben oltre le pagine di cronaca per coronare l’ambizione di cantare l’essenza del delitto, creando scenari mirati con finalità quasi didascaliche, catturando l’ascoltatore con costruzioni artefatte volte a mettere in evidenza quella che Hannah Arendt definiva la banalità del male.
Corpi bruciati (Westfall, Okkervil River, 2002), strangolamenti, coltellate, fucilate (Omie Wise, Banks Of The Ohio, Little Sadie, riconducibili al filone della musica popolare e portate al successo da più interpreti), le murder ballad espongono un campionario di brutalità senza alcuna censura o addolcimento: la crudezza della narrazione anzi non fa che acuire il senso di straniamento dell’ascoltatore.
When I killed her it was so easy
That I wanted to kill her again
I got down on both of my knees
She ain’t coming back again3
It’s in my hair
There’s blood in the sink
I can’t calm down, I can’t think
I keep calling
There’s blood in the trunk
I can’t calm down
Pick up!4
I’ve been waiting for this
I have been waiting for this
All you people in TV land
I will wake up your empty shells
Peak-time viewing blown in a flash
As I burn into your memory cells
‘Cos I’m alive5
Non si può infine non citare quello che forse è il maestro indiscusso del genere, l’australiano Nick Cave, che alle murder ballad ha dedicato anche un concept album. La sua opera simbolo è indubbiamente Where the wild roses grow, canzone che riassume ed esalta tutti i tratti salienti delle canzoni dedicate alla morte e all’omicidio: lo sfondo passionale del delitto, la crudezza del movente (And I kissed her goodbye, said: “All beauty must die”) raccontato dalla bocca dell’omicidio, le lente strofe di avvicinamento al momento culminante della morte della donna amata. La canzone si snoda come duetto, raccontando attraverso la voce di Cave il punto di vista dell’assassino e tramite Kylie Minogue quello della vittima; il video stesso non fa che enfatizzare ogni scena e contribuire al messaggio ultimo della canzone, a partire dalle mani insanguinate di Cave nella scena di apertura e dal serpente d’acqua che striscia sul “cadavere” della Minogue, simbolo di profanazione per di più dalla chiara allusione sessuale.
(per continuare la lettura cliccare su “4”)