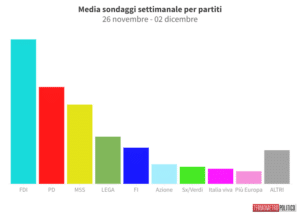Le riforme pensionistiche in Italia dall’avvento della Repubblica ad oggi

Le riforme pensionistiche in Italia dall’avvento della Repubblica ad oggi
Il sistema pensionistico in Italia è sempre stato al centro del dibattito economico e politico. Fin dalla nascita della Repubblica, infatti, il tema della pensioni ha rappresentato un pilastro del welfare, diventando sempre più complesso a causa dei cambiamenti demografici, sociali ed economici. Nel prosieguo dell’articolo analizzeremo l’evoluzione delle riforme pensionistiche per comprendere come l’Italia abbia cercato di garantire un equilibrio tra sostenibilità dei conti pubblici e tutela dei diritti dei lavoratori.
Le origini del sistema pensionistico
La Costituzione del 1948, mediante l’articolo 38, sancisce il diritto ai cittadini inabili al lavoro o sprovvisti dei mezzi necessari per vivere a ricevere il sostegno dello stato. Già all’epoca, di conseguenza, l’impianto previdenziale era legato a logiche di solidarietà sociale. Il sistema si basava sul metodo “retributivo puro”: la pensione era calcolata in base alle ultime retribuzioni percepite, senza alcun tipo di legame con i contributi effettivamente versati.
Nei due decenni successivi, l’Italia visse un periodo di forte crescita economica e industriale. Il sistema previdenziale nazionale si ampliò, con l’estensione della copertura assicurativa a diverse categorie di lavoratori autonomi e dipendenti. Le pensioni, di fatto, divennero uno strumento di coesione sociale di fondamentale importanza.
Gli anni ‘70 e ‘80: espansione e criticità
Il quadro mutò nel 1969, allorquando la riforma Brodolini-Giolitti introdusse il calcolo della pensione basato sulle ultime retribuzioni. Questo sistema fu estremamente vantaggioso per i lavoratori, soprattutto perché la stessa forniva la possibilità di accedere alla pensione a condizioni particolarmente vantaggiose: le donne sposate con figli potevano incassare l’assegno pensionistico dopo 14 anni di lavoro, mentre gli uomini dovevano attendere soltanto sei anni in più per raggiungere “quota 20”.
Questo fenomeno prese il nome di “baby-pensioni”, che portarono alla manifestazione dei primi squilibri nel corso degli anni ‘80. Il sistema retributivo, infatti, generava una spesa crescente, mentre i tassi di natalità erano in discesa e l’aspettativa di vita aumentava. Lo squilibrio tra lavoratori attivi e pensionati si fece man mano più evidente, costringendo allo stato di dover intervenire.
Le grandi riforme strutturali degli anni ‘90
Il riassetto del sistema pensionistico italiano avvenne nell’ultimo decennio dello scorso millennio. Il primo a metterci mano fu il Governo Amato (1992), che introdusse l’adeguamento graduale dei requisiti di età per il pensionamento e iniziò a ridurre i vantaggi del sistema retributivo. Venne aumentata l’età pensionabile e furono introdotti meccanismi per contenere la spesa.
La svolta epocale, tuttavia, si registrò tre anni dopo durante il governo Dini. L’Italia, infatti, passò dal metodo retributivo a quello contributivo, in cui l’assegno viene esclusivamente calcolato sulla base dei contributi effettivamente versati lungo l’arco della carriera lavorativa, con il cosiddetto “montante contributivo” rivalutato nel tempo. La riforma si rese necessaria per dare maggiore sostenibilità ai conti pubblici, ma fu introdotta gradualmente creando per anni una coesistenza tra vecchi e nuovi sistemi.
Le riforme introdotte nel primi decenni del nuovo millennio
L’obiettivo di perseguire l’equilibrio dei conti pubblici fu il “marchio di fabbrica” anche delle riforme dei primi anni del 2000. Nel 2004, ad esempio, la Legge Maroni introdusse lo Scalone, ovvero l’innalzamento repentino dell’età pensionabile, che fu corretto, poi, nel cosiddetto “scalino”. Negli anni successivi, inoltre, furono ideati meccanismi di flessibilità in uscita e incentivi a rimanere al lavoro.
Tutto cambiò radicalmente nel 2011, quando l’Italia fu costretta a varare la riforma Fornero in una situazione di grande instabilità dei conti pubblici e con l’Italia a un passo dal “default”. La riforma prevedeva l’innalzamento dell’età pensionabile correlata all’aspettativa di vita, oltre all’applicazione generalizzata del sistema contributivo e l’introduzione di requisiti decisamente più stringenti per accedere alla pensione anticipata.
Le modifiche recenti e le riforme in discussione oggi
Negli ultimi anni, superata la fase di grande incertezza che portò al varo della Riforma Fornero, i governi hanno cercato di introdurre maggiore flessibilità: da “quota 100” (pensione con 62 anni d’età e 38 anni di contributi) a “quota 102” (pensione con 64 anni d’età e 38 di contributi), passando per “opzione donna” e “l’ape sociale”, non sono certo mancati gli interventi temporanei e straordinari per mitigare le rigidità della riforma pensionistica del 2011.
Attualmente, il tema è piuttosto vivace nel nostro Parlamento, anche perché, al giorno d’oggi, è piuttosto complesso effettuare il calcolo della pensione che spetterà ad un cittadino nel momento in cui ne avrà diritto. Alcuni esponenti politici, ad esempio, spingono perché venga riconosciuto l’assegno pensionistico al raggiungimento dei 41 anni di contributi, indipendentemente dall’età anagrafica.
SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK TWITTER INSTAGRAM
Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it