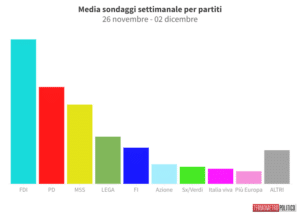Corpi in guerra: la storia dei bordelli militari dalle colonie alle donne di conforto

La guerra ha sempre generato spazi liminali, dove le regole della società civile vengono sospese. In quei margini si sviluppano pratiche di sopravvivenza, potere e sfruttamento — tra queste, la prostituzione legata alla presenza militare è una delle più persistenti e complesse. Dall’Europa coloniale all’Asia occupata, fino alla Corea del dopoguerra, le cosiddette donne di conforto e le camptown women mostrano come i corpi femminili siano stati integrati, controllati e impiegati in modo funzionale alle logiche militari. Oggi, una nuova storiografia cerca di distinguere tra sfruttamento sistemico, consenso parziale e narrazioni ideologiche.
Bordelli di guerra: una struttura antica
L’uso organizzato della prostituzione in tempo di guerra è attestato sin dall’antichità. Le città greche e romane regolamentavano bordelli per soldati di passaggio. Durante le Crociate, accampamenti mobili di donne seguivano le truppe. In epoca moderna, eserciti europei crearono bordelli autorizzati nelle colonie — in Algeria, India e Indocina — utilizzando donne indigene per “servire” le truppe in un contesto di dominio razziale e militare.
Nelle due guerre mondiali, il fenomeno si fece più istituzionale. La Germania nazista creò più di 100 bordelli militari nei territori occupati. La Francia istituì maisons tolérées nelle retrovie. Il fine dichiarato era duplice: ridurre la diffusione di malattie veneree e mantenere la disciplina tra le truppe.
Le donne di conforto: oltre la retorica
Nel contesto asiatico, il caso delle donne di conforto resta tra i più discussi. Tra il 1932 e il 1945, l’esercito giapponese organizzò centinaia di stazioni di conforto (comfort stations) in Corea, Cina, Manciuria, Filippine e Indonesia. Decine di migliaia di donne, in prevalenza coreane, furono reclutate attraverso agenti locali. La versione dominante in Corea del Sud presenta queste donne come vittime di rapimenti e violenze sistematiche.
Tuttavia, il libro The Comfort Women Hoax di J. Mark Ramseyer e Jason M. Morgan propone una lettura fortemente alternativa. Basandosi su documenti giapponesi, contratti dell’epoca e testimonianze ignorate dalla storiografia militante, gli autori sostengono che molte donne di conforto firmarono accordi lavorativi, ricevevano una paga e usufruivano di controlli sanitari regolari.
Ramseyer e Morgan affermano che molte donne di conforto ricevevano pagamenti in denaro ben oltre lo stipendio medio di un soldato giapponese dell’epoca. Esse ricevevano da 500 a 1 000 yen in anticipo, mentre lo stipendio di un sergente giapponese era di circa 30 yen al mese
Un compenso iniziale di 500–1 000 yen rappresentava quindi tra 16 e 33 volte lo stipendio mensile di un militare medio, e, secondo gli autori, molte donne provenienti da famiglie povere avrebbero scelto volontariamente quella strada.
Secondo questa visione, il sistema era più simile a una forma regolamentata di lavoro sessuale che a uno schiavismo militare.
Queste affermazioni hanno suscitato reazioni violente in Corea del Sud e negli ambienti accademici internazionali. Tuttavia, pongono una domanda legittima: quanto delle narrazioni dominanti è frutto di revisioni post-belliche, pressioni ideologiche o interessi politici?
Le camptown women: il silenzio dopo la guerra
Dopo il 1945, un nuovo fenomeno emerse vicino alle basi americane in Corea del Sud: le camptown women. Queste donne — spesso provenienti da contesti rurali poveri — lavoravano in villaggi noti come kijichon, fornendo servizi sessuali ai soldati americani. Non si trattava di una coercizione diretta, ma di una forma di dipendenza economica e marginalizzazione. Il governo sudcoreano stesso, nei decenni della Guerra Fredda, cooperò attivamente nel regolare queste comunità, vedendole come strumenti utili per mantenere i buoni rapporti con l’esercito USA.
Le donne ricevevano un compenso, erano soggette a visite mediche e vivevano in aree recintate e sorvegliate. In molti casi, la loro attività era formalmente autorizzata. Alcuni studi recenti sottolineano come il sistema delle camptown non fosse solo tollerato ma incentivato, trasformando queste donne in una sorta di “risorsa strategica” per l’alleanza militare.

Altri casi: colonialismo, logistica e profitto
Nel Vietnam della guerra americana, quartieri interi sorsero attorno alle basi militari, dove donne locali offrivano servizi sessuali in cambio di riso, sigarette o valuta. Anche in Africa — in Liberia, Congo e Sudan — durante i conflitti civili, sono stati documentati episodi di sfruttamento sessuale attorno ai contingenti stranieri o mercenari, talvolta senza alcuna organizzazione formale, ma con tolleranza implicita da parte delle autorità.
In questi casi, a differenza delle stazioni di conforto giapponesi o dei kijichon coreani, manca una struttura ufficiale. Tuttavia, la logica resta simile: creare uno sfogo sessuale per le truppe, contenere i disordini, e sfruttare economicamente la disparità di potere tra occupanti e occupati.
Conclusione: una realtà scomoda ma ricorrente
La storia delle donne di conforto e delle camptown women mostra che la prostituzione militare non è un incidente morale, ma una componente ricorrente dei conflitti armati. A volte imposta, a volte contrattata, a volte accettata per necessità, questa realtà continua a porre interrogativi scomodi: su chi controlla i corpi durante la guerra, su come si costruisce la memoria, e su quanto davvero comprendiamo la voce delle donne coinvolte.
Non tutte le storie rientrano negli estremi della vittima o della collaboratrice. Alcune sono ambigue, contraddittorie, e proprio per questo meritevoli di essere raccontate senza pregiudizi. Guardare alla storia con più strumenti, più fonti e meno ideologia può aiutare a costruire una memoria storica più onesta — anche quando si tratta di un tema difficile come quello della prostituzione militare.